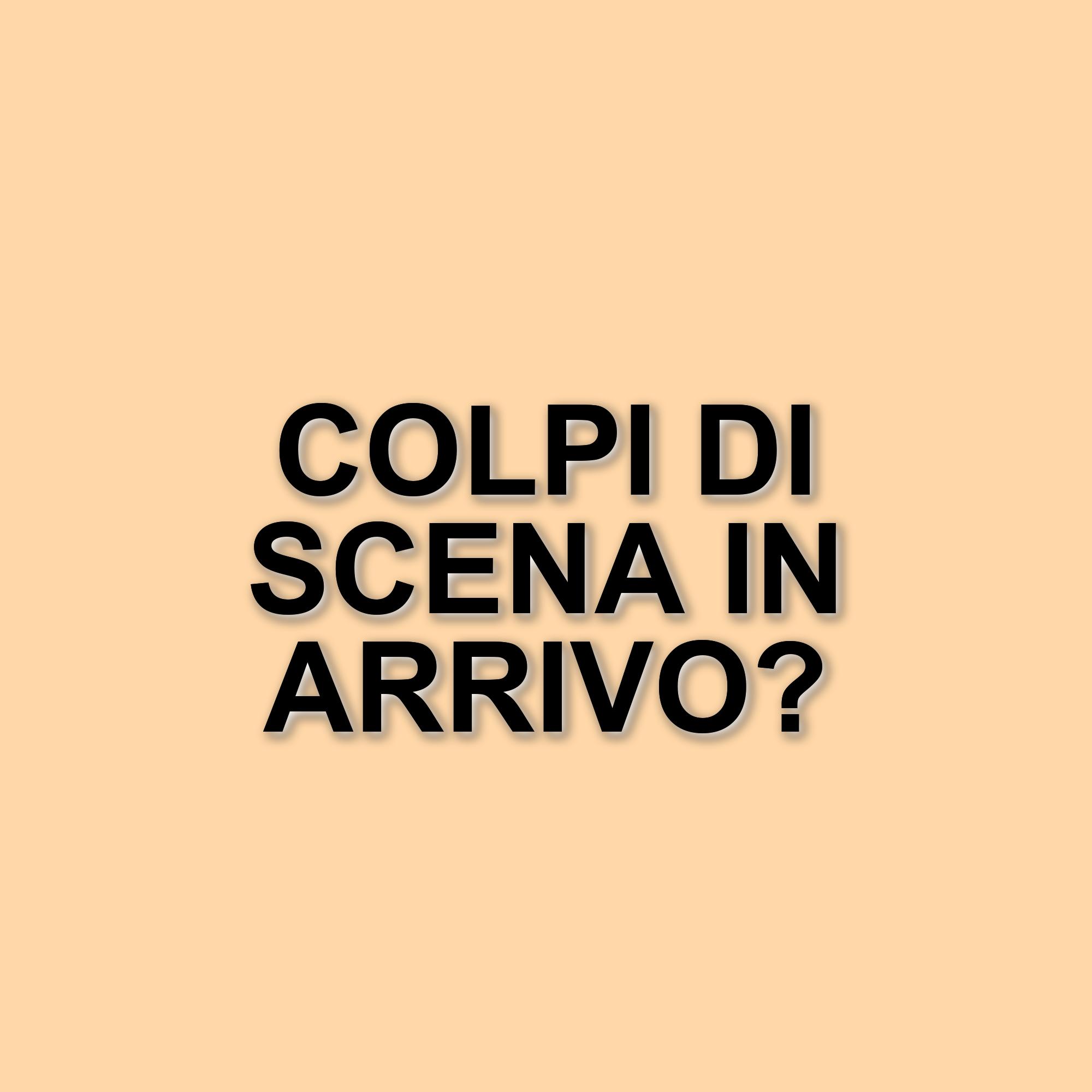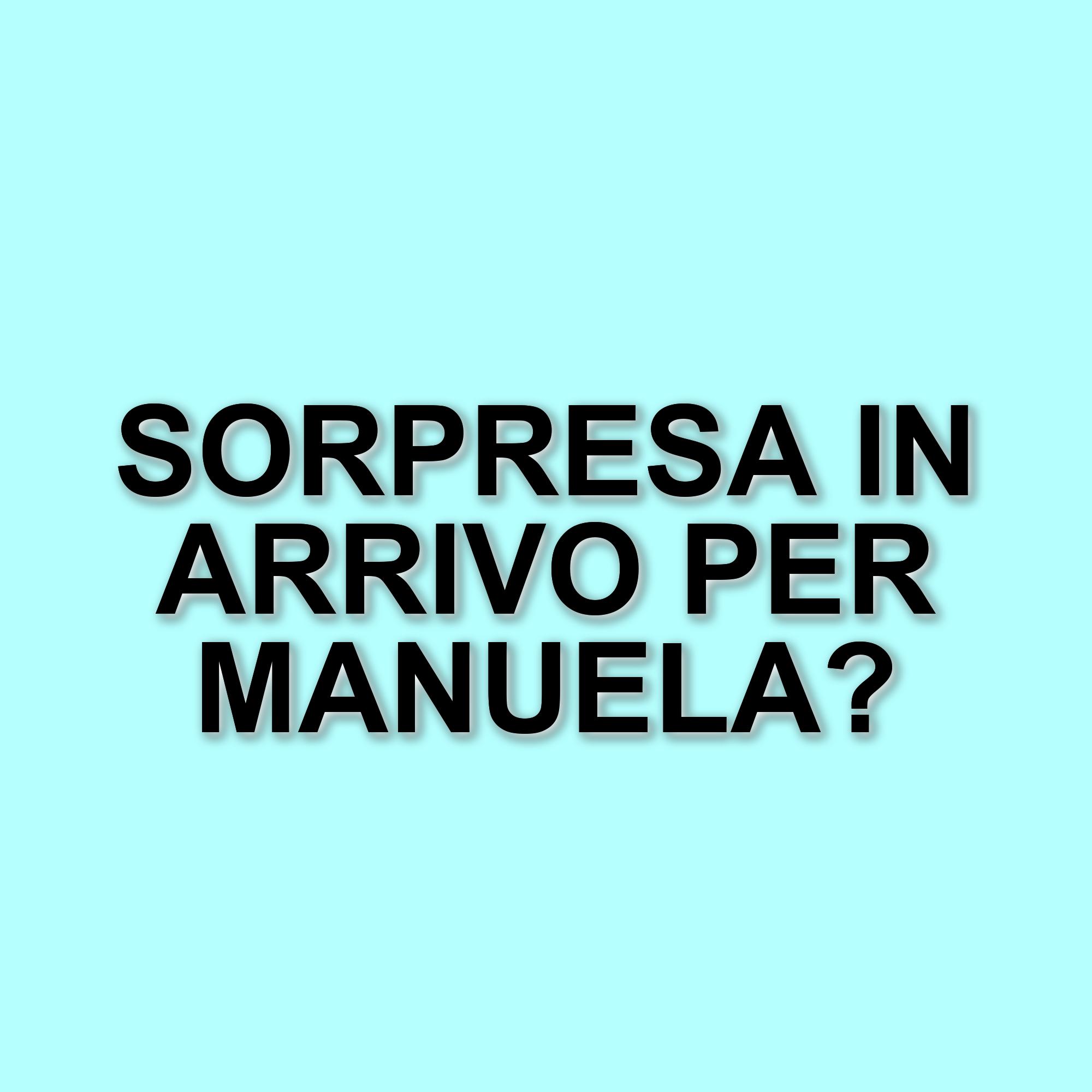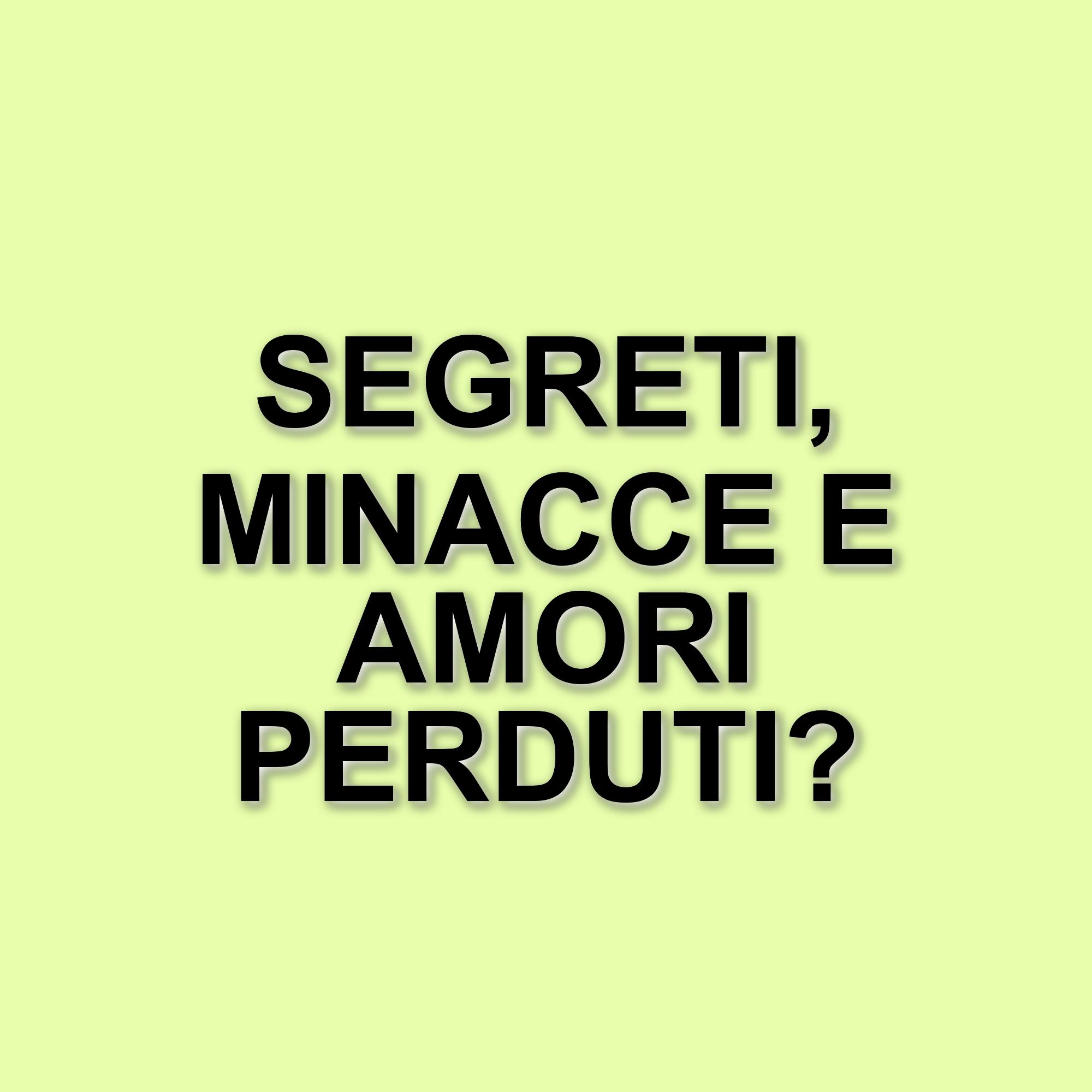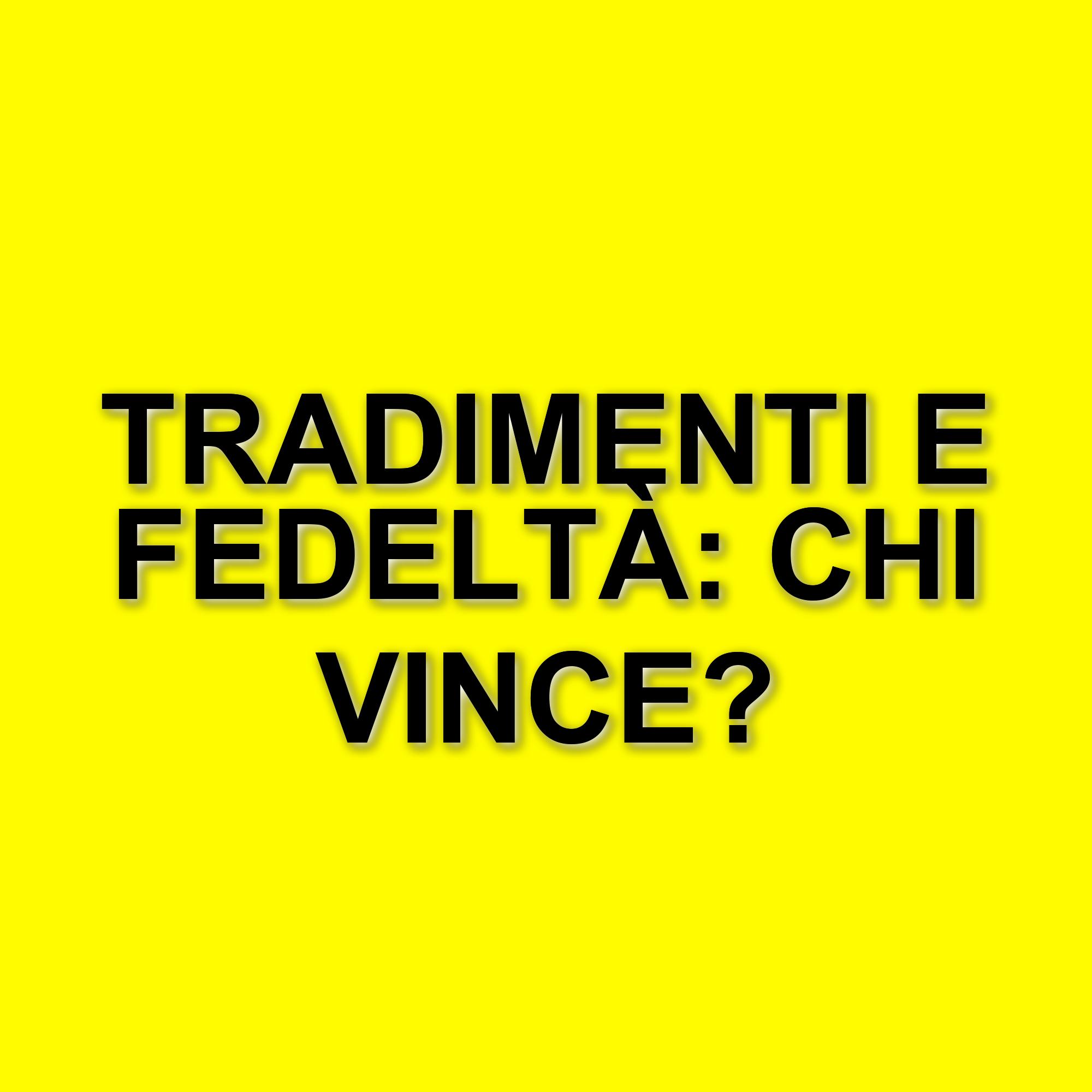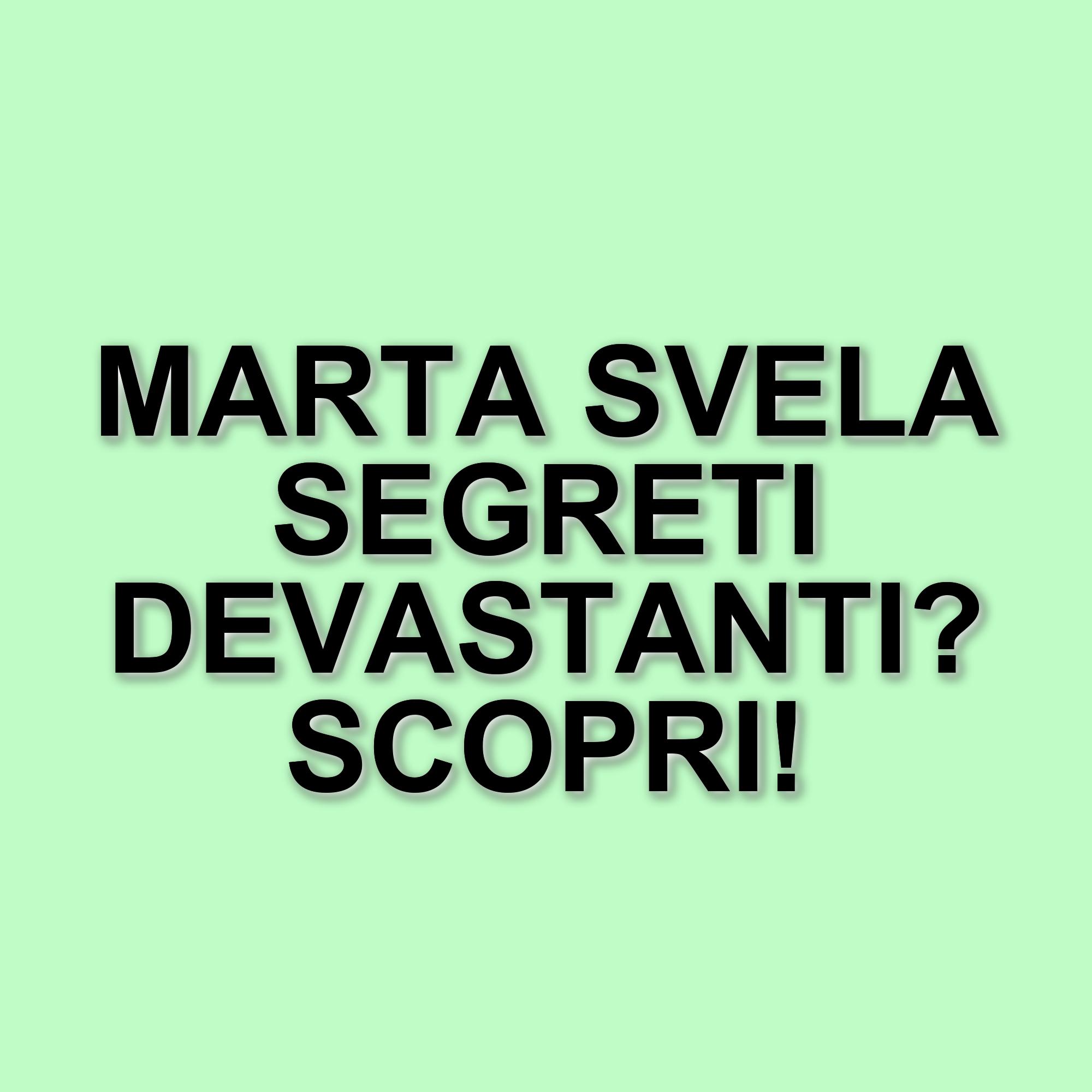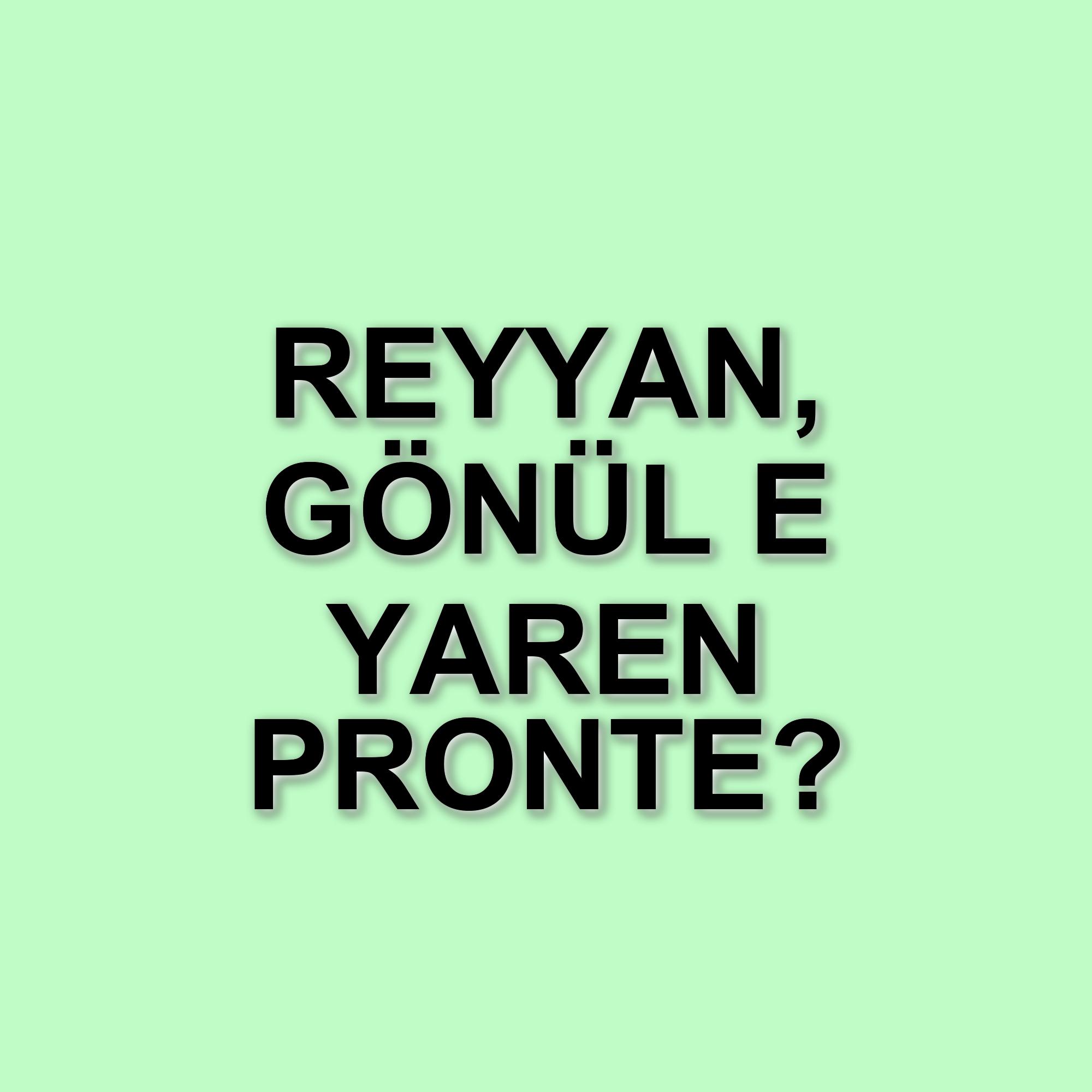Filippo Gravino racconta come, ispirandosi alle parole di Michela Murgia, ha dato vita a una serie intensa e coinvolgente, intitolata Storia della mia famiglia, che debutterà su Netflix dal 19 febbraio. Il regista e sceneggiatore ha voluto dare una nuova veste al concetto di famiglia, andando oltre i modelli tradizionali per esplorare relazioni genuine e complesse. Tra gli elementi chiave del racconto c’è l’incontro con il produttore Nicola Serra, che, con poche parole, ha creduto in una storia ricca di sfumature e contraddizioni. In questo contesto, l’attore Eduardo Scarpetta, interpretando il terminale Fausto, assume un ruolo centrale, rappresentando non solo il dolore della malattia, ma anche il calore umano di una famiglia che si prepara ad affrontare il dolore imminente con speranza e determinazione. All’interno della narrazione, personaggi come Valerio, Lucia e gli altri aiutano a delineare un quadro realistico in cui il rapporto tra sangue e affetto scelto si intreccia in un viaggio che attraversa tempi e sentimenti, offrendo uno spaccato autentico e riflessivo sulle dinamiche internalizzate e sulle aspettative che tradizionalmente si hanno nei confronti dei legami familiari.

Eduardo Scarpetta e l’interpretazione della malattia in storia della mia famiglia
Filippo Gravino ha voluto raccontare una storia che scava nelle radici delle relazioni, partendo proprio dalla rappresentazione di una malattia che segna in modo profondo l’esistenza di un personaggio centrale. Nel corso delle interviste, Gravino confida: “Quando ho scritto Storia della mia famiglia avevo in mente le parole di Michela Murgia. La sua idea di famiglia è stata sostanziale per la stesura del racconto e credo debba essere una fonte di ispirazione per tutti”. Questo spirito si riflette nel personaggio di Fausto, interpretato con intensità da Eduardo Scarpetta, il quale, ricordando il vissuto del padre afflitto da una simile malattia, ha saputo documentarsi in maniera approfondita sul tema. «Ho letto tutto ciò che c’era da sapere sul male che affligge il personaggio», ha dichiarato Scarpetta, mettendo in luce il suo impegno nel comprendere quella condizione che trasforma la vita quotidiana in un continuo sforzo di resistenza. Durante le riprese, il clima di lavoro si è caratterizzato per la cura reciproca, creando un ambiente in cui, nonostante il peso emotivo della malattia, ogni membro del cast si è preso cura degli altri, costruendo rapporti proficui e solidali. L’attore ha sottolineato come il set sia stato un luogo sicuro, non solo per esprimere la sua esperienza personale, ma anche per stimolare l’improvvisazione e il confronto, elementi fondamentali per dare realismo e profondità alla narrazione. La rappresentazione della malattia non è mai stata semplificata in un vero e proprio cliché, ma è divenuta il fulcro attorno a cui ruotano le dinamiche familiari, offrendo spunti di riflessione sul senso dello stare insieme di fronte alle avversità e sulla forza che si trova nella fragilità degli individui.
Inoltre, il modo in cui la storia di Fausto si intreccia con quella degli altri personaggi permette di apprezzare un ritratto intimamente umano, dove il dolore si mescola a momenti di ironia e speranza. La scrittura di Gravino, priva di intenti ideologici, abbraccia il cambiamento dei tempi e invita gli spettatori a mollare i preconcetti imposti da schemi troppo rigidi. Le parole dell’autore, ricordando i momenti in cui ha insegnato a fidarsi dell’umanità, assumono un significato ancor più profondo all’interno del percorso narrativo. Il racconto, fatto di sfaccettature e contrasti, si fa portavoce di un messaggio universale: accettare la fragilità significa apprezzare l’autenticità dei rapporti, un invito a non perdere fiducia nell’altro anche nei momenti più difficili. Il lavoro di Eduardo Scarpetta, con una preparazione basata sull’esperienza personale e sulla condivisione sincera, regala una visione nuova e toccante della malattia, trasformandola in un elemento che, paradossalmente, unisce e rafforza i legami umani.
Legami autentici e la rivoluzione della famiglia tradizionale
Il concetto di famiglia al centro di Storia della mia famiglia si distacca dalle imposizioni degli stereotipi, abbracciando una visione moderna in cui la tradizione convive con il cambiamento. Filippo Gravino testimonia: «Non c’è mai un intento ideologico dietro ai miei lavori», spiegando come abbia saputo radicare la sua scrittura in esperienze personali e nell’amore incondizionato verso i suoi cari. In questo quadro, anche il giovane attore Massimiliano Caiazzo ha trovato nel personaggio di Valerio uno specchio delle contraddizioni e delle fragilità che caratterizzano le dinamiche familiari contemporanee. La sua interpretazione, che si fonda sul profondo legame emozionale con il personaggio di Fausto, rivela come la dipendenza dalla cocaina rappresenti, simbolicamente, la ricerca disperata di connessione e appartenenza in una realtà in cui le aspettative vengono spesso travisate. Il racconto, infatti, non si limita a delineare i contorni del dolore, ma si sofferma sul percorso di crescita individuale e collettivo, evidenziando come una realtà familiare possa trasformarsi in un laboratorio di sperimentazione emotiva.
Al medesimo modo, attori come Antonio Gargiulo e Vanessa Scalera contribuiscono a dare voce a personaggi che sfidano la tradizionale immagine della famiglia. Gargiulo, che ha raccontato il proprio passaggio dal sud al nord per inseguire il sogno della recitazione, definisce il concetto di famiglia come un insieme di rapporti scelti e condivisi nel tempo. La sua interpretazione di Demetrio, amico intimo di Fausto, evidenzia come il dolore per la perdita possa trasformarsi in un’opportunità per raggiungere una nuova consapevolezza e per esprimere se stessi in maniera più completa. D’altra parte, Vanessa Scalera, nel vestire il ruolo di Lucia, critica l’idea di una madre perfetta e immodificabile: «Io non sono genitore, ma non capisco per quale motivo si debba avere sempre in mente la convinzione che una madre deve essere giusta. La donna santificata da nascondere dietro al velo. Essere madre, però, non significa essere Maria di Nazareth». Questa riflessione apre uno spazio di dialogo sulla natura dei legami, mettendo in risalto come l’amore autentico nasca proprio dall’accettazione delle imperfezioni individuali e collettive. Il lavoro del regista Claudio Cupellini, che ha saputo amalgamare risate e commozione nel suo approccio narrativo, rafforza questo messaggio: i rapporti familiari, che siano di sangue o scelti, si fondano sulla condivisione e sulla forza del gruppo. La serie, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra, si presenta così come un inno alla speranza, capace di invitare lo spettatore a scoprire un nuovo modo di concepire e vivere la famiglia, in cui la vulnerabilità diventa dimora di una profonda autenticità.
CONDIVIDI COI TUOI AMICI!